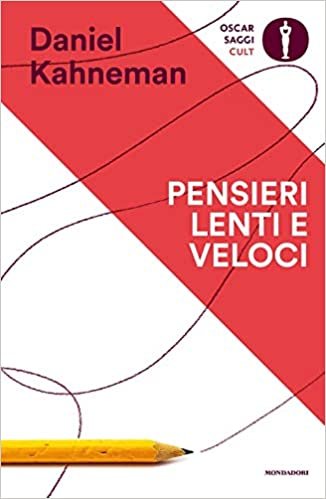Daniel Kahneman ci spiega che la maggior parte dei nostri pensieri e comportamenti è generata da un sistema automatico del cervello, e ci insegna ad attivare il ragionamento vero per ridurre gli errori cognitivi.
Leggendo il riassunto di Pensieri lenti e veloci scoprirai come prendere decisioni migliori, comunicare meglio ed essere più felice.
Ecco l’indice:
Di cosa parla Pensieri lenti e veloci
Pensieri lenti e veloci, in inglese Thinking: fast and slow, illustra le due modalità in cui funziona la mente: un sistema automatico protagonista delle nostre decisioni e un sistema riflessivo che si attiva di rado.
Infatti, noi esseri umani ci crediamo razionali ma siamo tutt’al più “razionalizzanti”: di solito seguiamo l’intuizione, cioè delle scorciatoie mentali, e a posteriori cerchiamo una logica che giustifichi le nostre azioni.
In questo libro confluiscono gli esiti delle ricerche che hanno portato Amos Tversky e Daniel Kahneman a gettare le basi dell’economia comportamentale dimostrando che quasi sempre, persino quando crediamo di perseguire in modo lucido e freddo i nostri interessi economici, siamo manovrati dall’emotività e accecati da bias cognitivi.
Questo libro ci offre una panoramica di meccanismi di valutazione e decisione che abbiamo elaborato nel corso dell’evoluzione per aumentare le nostre probabilità di sopravvivenza e che, nel mondo di oggi, rischiano di farci prendere molte decisioni sbagliate.
Conoscendo questi meccanismi del cervello, ti verrà più facile disinnescarli.
Il libro però è lungo: l’edizione italiana contiene ben 730 pagine. Comincia dal riassunto.
Chi è Daniel Kahneman
Daniel Kahneman è uno psicologo israeliano di fama mondiale scomparso di recente, che ha segnato la storia della psicologia cognitiva e dell’economia grazie al lavoro condotto insieme al collega Amos Tversky. Kahneman ha studiato psicologia all’Università Ebraica di Gerusalemme e ha conseguito un dottorato presso l’Università di Chicago. La sua carriera accademica lo ha portato a insegnare in prestigiose istituzioni, tra cui Princeton, e a lavorare come consulente per organizzazioni governative e private.
Nel 1979, insieme a Tversky, Kahneman ha formulato la Teoria dei prospetti, che ha descritto il modo in cui le persone prendono decisioni in condizioni di incertezza rivoluzionando la comprensione del comportamento economico, fino ad allora ritenuto razionale per definizione. Secondo la teoria, poiché la sofferenza per una perdita è maggiore della gioia per un guadagno dello stesso ammontare, le persone tendono a evitare rischi quando si tratta di guadagnare, mentre sono disposte a rischiare per evitare le perdite.
Nel 2002, Daniel Kahneman ha ritirato il Premio Nobel per l’Economia, da solo perché Amos Tversky era già scomparso nel 1996. Oggi lo sono entrambi, ma le loro scoperte continuano a influenzare tanti settori e in particolare il marketing e la finanza.
I due sistemi della mente secondo Kahneman
Kahneman e Tversky hanno appurato che, quando deve prendere decisioni per agire, il cervello umano può funzionare in due modalità:- Sistema 1: veloce, basato su automatismi e scorciatoie mentali;
- Sistema 2: lento e riflessivo.
Il sistema 1 di Pensieri lenti e veloci
Il sistema 1, veloce e automatico, è sempre in funzione e consuma pochissima energia. È la modalità fondamentale in cui lavora il nostro cervello. Gestisce tutte le attività che possiamo svolgere senza pensare e senza sforzo: guidare su una strada tranquilla e conosciuta, camminare al passo che ci viene naturale. Il sistema 1 è il nostro pilota automatico. È lui che gestisce tutte le attività di routine, facendo appello al sistema 2 solo in caso di compiti complessi che da solo non riesce a svolgere. Purtroppo, anche in questi casi, tende a dire la sua con intuizioni e spunti, che il sistema riflessivo spesso convalida senza indagare per pura pigrizia. Anche se la tua parte razionale è “convinta di avere il controllo e di conoscere le ragioni delle proprie scelte”, la maggior parte delle tue azioni deriva in tutto o in parte dal sistema automatico. È il sistema 1 che:- Nota che un oggetto è più lontano di un altro.
- Ci fa orientare verso la sorgente di un suono improvviso.
- Completa la frase “pane e…”.
- Capisce frasi semplici.
- Associa caratteristiche a stereotipi.
- Cerca nella memoria per associazione di idee, evitando di scandagliare tra tutti i ricordi ogni volta che ci serve un’informazione.
- Pesca risposte più o meno plausibili in base alle esperienze più recenti o più emotivamente significative, a stereotipi e rapporti causa-effetto apparenti.
Il sistema 2 di Pensieri lenti e veloci
Il sistema 2 è quello che si occupa di svolgere o monitorare i compiti difficili. Per attivarlo devi concentrarti. È lento, riflessivo e consuma molta energia, per questo cerca di intervenire il meno possibile e spesso si limita a convalidare i suggerimenti istintivi del sistema 1. Il sistema 2 entra in funzione quando dobbiamo:- Cercare una donna con i capelli bianchi in mezzo a una folla.
- Frugare nella memoria per identificare un suono molto strano.
- Mantenere un passo più veloce di quello che ci riesce naturale.
- Contare quante volte compare la lettera A in una pagina.
- Dare a qualcuno il numero di telefono.
- Confrontare le caratteristiche di due lavatrici.
- Compilare la dichiarazione dei redditi.
- Mantenere un comportamento adeguato nelle situazioni sociali.
Euristiche e bias secondo Kahneman
Se dovessimo fermarci a riflettere su ogni azione che compiamo, la nostra vita sarebbe un inferno, o più probabilmente non ne avremmo una, perché la specie umana si sarebbe estinta molte migliaia di anni fa. Gli automatismi usati dal sistema 1 si chiamano euristiche e possono essere utili, ma anche causare errori della percezione o bias.
Ecco alcune euristiche e bias descritti da Kahneman in Pensieri lenti e veloci:
Euristica della rappresentatività
Tendiamo a valutare la probabilità di un evento basandoci su stereotipi e trascurando i dati statistici. A questo proposito, Kahneman racconta di un esperimento in cui lui e Tversky chiesero a un gruppo di persone se fosse più probabile che un uomo timido e preciso fosse un bibliotecario o un agricoltore.
Tu cosa avresti risposto?
La maggior parte delle persone, basandosi sulla propria rappresentazione mentale delle due professioni, direbbe che si tratta quasi certamente di un bibliotecario. In realtà, la risposta corretta supportata da dati statistici è quella opposta: poiché al mondo ci sono molti più agricoltori che bibliotecari, è più probabile che la persona in questione sia un agricoltore, a prescindere dal carattere.
Euristica della disponibilità
Quando valutiamo la probabilità di un evento, ci facciamo condizionare da quanto facilmente riusciamo a ricordare esempi simili. Se altri fatti del genere ci sono rimasti impressi, tendiamo ad avere la sensazione che accadano di frequente. La nostra stessa percezione del pericolo è influenzata da quanto è vivo nella nostra memoria il ricordo di un certo tipo di incidente o aggressione, molto più che dalla sua reale incidenza.
Ad esempio, tante persone hanno paura di prendere l’aereo, mentre quasi nessuno ha paura di prendere l’auto, nonostante volare sia molto meno pericoloso che viaggiare in macchina.
Succede perché gli incidenti aerei sono in genere più drammatici di quelli automobilistici, poiché di solito nessun passeggero riesce a salvarsi; inoltre, i media danno ampio spazio a questo genere di notizie, portatrici di emozioni negative capaci di imprimerle per sempre nel nostro subconscio.
Effetto ancoraggio
La prima informazione che riceviamo diventa un’ancora cognitiva: un riferimento che condiziona il modo in cui percepiamo quelle successive.
Ecco perché le aziende ci mostrano sempre un prezzo iniziale più alto insieme al prezzo effettivo del prodotto: per quanto conosciamo il trucco, per quanto lo abbiamo visto mettere in atto milioni di volte nel marketing, non possiamo evitare di esserne influenzati.
Eccesso di fiducia
Insieme alla scarsa autostima, anche la fiducia eccessiva nelle proprie abilità e conoscenze è un problema diffuso, che ostacola la valutazione obiettiva delle situazioni.
Si tratta di un bias molto problematico in contesti complessi come la finanza, poiché può spingere gli investitori a ignorare segnali di rischio pensando di avere tutto sotto controllo, col risultato di subire perdite evitabili.
Bias di conferma
Ci piace pensare di avere ragione. Così siamo portati a cercare informazioni che confermano le nostre convinzioni e ignorare quelle che potrebbero contraddirle.
Ad esempio, una persona convinta dell’efficacia di una dieta preferirà dare ascolto alle testimonianze positive di chi l’ha provata ed eviterà di approfondire le notizie e gli studi scientifici che ne smentiscono l’efficacia o mettono in rilievo possibili rischi.
Priming
I nostri ricordi più recenti influenzano le associazioni di idee che usiamo per risolvere quesiti e problemi. Ad esempio, quando completiamo la parola S_ _P come soup (zuppa) dopo aver pensato alla cena e come soap (sapone) dopo aver pensato alla doccia.Illusione del ricordo
Se ti chiedono di verificare una lista di celebrità, crederai siano famosi tutti quelli che hanno nomi che ti suonano familiari, per una sorta di déjà vu illusorio.Effetto esposizione
La familiarità ci fa sembrare tutto più positivo: la ripetizione di stimoli neutri e perfino di parole straniere incomprensibili alimenta un senso di abitudine e fiducia.Illusione di causalità
Il sistema 1 vede nessi causali anche dove non ci sono e il sistema 2 spesso li convalida. Lo sanno bene i giornalisti, che amano suggerire rapporti causa-effetto inesistenti ma affascinanti e a volte si contraddicono. Ad esempio, nel 2003 l’agenzia di stampa Bloomberg pubblicò a distanza di mezz’ora questi due titoli: “Buoni del tesoro in rialzo: la cattura di Saddam Hussein potrebbe non fermare il terrorismo” e “Buoni del tesoro in ribasso: la cattura di Saddam Hussein aumenta l’attrattiva dei titoli ad alto rischio”.“Qualsiasi evento saliente recente è candidato a diventare il nucleo di una narrazione causale.”